-
La Moda, brand alla potenza
Venerdì in Cattolica guardavo le ragazze a lezione. Cappotto color cammello (tipo il classico beige di Max Mara, con cintura da annodare come una vestaglia),

capelli lunghi, dolcevita o camicia in popeline con righe maschili. Occhiali e computer Apple su cui prendere appunti.
Mentre facevamo lezione, davanti a noi c’erano tanti coperchi grigio/argento con in mezzo una mela.
In Statale le ragazze sono diverse (Rosa si è laureata la scorsa settimana e sembrava una socialista americana degli anni ’40, in total brown) . In Bicocca va il tailleur pantalone.
Giovedì sera sono andata a vedere la mostra su Moroni alle Gallerie d’Italia. E ieri con Paola e le amiche d’infanzia a vedere Boldini e De Nittis a Novara. In entrambe le mostre (così diverse per epoca e suggestioni) gli abiti, i tessuti, gli accessori erano rappresentati con una perizia, una ricchezza, una definizione da lasciare sbalorditi. Crinoline, velluti, voiles, passamanerie, bottoni, perle che sembravano uscire dalla tela, morbidi e lucidi, come fossero veri.
Forse si tratta di deformazione professionale ma i vestiti per me sono un brand alla potenza, perché ci stanno attaccati, perché parlano di loro ma soprattutto parlano di noi. Cosa sarebbero le fascinose donne di Boldini senza quei rasi bianchi che sembra di sentire il fruscio della seta?

E il cavaliere in rosa di Moroni che cosa voleva raccontare con il suo incredibile abito color corallo?

Più della tua casa, della tua mensa , della tua macchina, della tua professione, gli abiti hanno il potere di rappresentarti in un batter d’occhio.
Sono un’arma per nasconderti o svelarti, per difenderti o esibirti.
Parlare di brand per gli yogurt o per la pasta, per i vaccini o per le automobili è un interessante esercizio di marketing. Tante sono le case history che io e Simona estraiamo dal cappello e raccontiamo ai nostri studenti.
Ma nessun prodotto ha il potere così prodigioso di raccontarci come un abito.
La moda è l’intruglio magico che ci rappresenta sul palcoscenico della vita.
-
Non basta essere poveri per essere buoni
Io, Silvia e Cate, la prima domenica del mese, facciamo i volontari alla mensa dell’Opera Cardinal Ferrari, non lontano dalla Bocconi e da Fondazione Prada.
Eppure lì nessuno studia e pochi si occupano di stile

I mangiatori di patate di Van Gogh Al centro diurno arrivano poche donne (per lo più straniere, vestite con ordine, gentili, cui il destino forse con malaugurato sgambetto ha tolto una opportunità, facendole scivolare in un dirupo) e molti uomini (di età e nazionalità miste) con zaini, trolley o borsoni in cui conservano i loro averi. Più sciupati, più tristi, più polemici e soli.
Questa settimana , sarà la pioggia che non dà tregua, saranno le porzioni di pasta che domenica erano più modeste del solito, c’era un certo nervosismo tra i carissimi (così si chiamano gli ospiti di OCF) che sedevano a tavola.
I soliti polemici (pancetta? dov’è la pancetta?) davano il loro meglio diventando quasi scurrili (mandi aff… il cuoco!) o perlomeno coloriti (entriamo affamati, usciamo morti di fame).
Per un attimo mi è venuta voglia di restituire alle frasi maleducate, una buona dose di risposte sarcastiche. Poi ho riflettuto sul fatto che il senso della dignità in persone che la hanno persa o la vedono in pericolo ad ogni passo (senza una casa, senza un lavoro, senza una famiglia) può sostanziarsi anche nella pretesa di una porzione abbondante o di un sorriso ad ogni costo che li confermi al centro dell’attenzione, almeno una volta, almeno alla mensa.
By the way la povertà e le sorti avverse non sono garanzia di bonarietà. Se esistono persone sgradevoli tra manager o vip danarosi, non c’è ragione statistica per cui anche un clochard non possa essere un imbecille.
Forse, dato che fuori fa freddo e probabilmente andranno a dormire sulla 90 anziché tra lenzuola fresche di bucato, ci portiamo a casa le loro intemperanze senza pretendere la cartolina del buon vecchino grato per il cibo e il servizio.
Troppi schiaffi dalla sorte. Troppi crediti dal destino. Hanno ragione, il cuoco doveva buttare qualche chilo in più di pasta.
-
Neve
Sabato sera la fashion week quasi volgeva al termine proprio mentre toccava il suo culmine. Con quel sapore un po’ malinconico che hanno le cose al massimo della maturità, a un passo dall’essere caduche. Come la finale di un torneo. O la domenica pomeriggio.

Emporio Armani FW24 ha messo la neve in passerella Io con gli amici del CAI, mentre a Milano si sparavano le ultime cartucce della Moda, mi avventuravo in una ciaspolata notturna a Bielmonte, Oasi Zegna (forse è destino che la moda ci metta sempre lo zampino).
Tutto era puro, bianco, silenzioso. Niente luna e stelle per via delle nubi. Solo una magica atmosfera ovattata e noi a avanzare con le torce frontali nel bianco. Abbiamo passato qualche ora in una dimensione sospesa e favolosa.
Mi vengono in mente la Neve del ’56, in cui Mia Martini canta una Roma imbiancata tutta pulita e lucida, oppure la Nevicata dell’85 a Milano, raccontata da Colaprico tra malavita e città sospesa sotto una assurda coperta immacolata. Ma anche i quadri di Angelo Inganni (è davvero un pittore, non solo una fermata del metro) con un Naviglio ottocentesco tutto imbiancato.

Ora mi chiedo: doveva per forza essere malinconica questa notte di sabato? Forse si, dovevo solo scegliere di che malinconia nutrirmi. Allora ho scelto la neve capace di evocare una nostalgia indefinibile, un abbandono dolce, un vagare silenzioso.
Quasi quasi mi spiace finisca l’inverno. In primavera mi toccherà una malinconia meno dolce. O un’altra neve in cui smarrirmi.
-
Se non lo sai fare, leggi le istruzioni
La mia prima volta alla Scala (Don Carlo, regia di Ronconi) avevo scarpine di vernice ai piedi e caramelle sfuse in borsa: nel caso mi fosse venuta la tosse, avrei potuto succhiare uno zuccherino senza che il fruscio della carta disturbasse i cantanti o chi stava intorno a noi. La zia di Vito (eravamo ospiti del suo palco) ci aveva bene istruito sulla condotta da tenere.

Nonostante la durata mostruosa dell’opera verdiana (oltre 5 ore di spettacolo), nonostante la nostra età (eravamo alle medie), nonostante ci dessimo il turno per appisolarci sugli strapuntini di seconda fila, né io né i miei fratelli abbiamo prodotto suoni, luci o vibrazioni che potessero dare noia agli altri spettatori. Quella prova di resistenza (a fissare l’orologio sopra il palco e la pelata degli spettatori di platea più che i carri pieni di teschi che si muovevano sulla scena) è stato un rito di passaggio.
Dopo i primi rudimenti educativi, la consuetudine al teatro ci ha reso familiari anche le leggi non scritte (leggere il libretto in anticipo, arrivare almeno 15 minuti prima dell’apertura del sipario, non applaudire a scena aperta a meno che non ci sia una reincarnazione della Callas, spegnere il cellulare – e riporlo bene, perché non cada con un tonfo sul più bello – , togliere il cappello, non fotografare, non filmare, non chiacchierare, non mangiare, non bere, non uscire se non all’intervallo, non correre al parcheggio mentre gli attori si inchinano a prendere i meritati applausi) e ci ha naturalmente indotto a rispettare le regole in sala (post Wagner certo; fino a qualche secolo fa in teatro si faceva di tutto, dal gioco d’azzardo all’amore, ma era un’altra epoca).
Ora mi chiedo: ma se non sei un assiduo amante del teatro (io sono inesperta di altre centinaia di cose), ci vuole tanto a leggere le istruzioni sul biglietto e a imitare quelli che stanno di fianco a te? A informarti brevemente sulle regole di base? Lo stesso vale per la piscina, la biblioteca, la discoteca, lo stadio, la chiesa, il torneo di tennis, una visita guidata al Quirinale, una udienza in Vaticano, una pista da sci alpino, una serata al pub.
Io non sono una esperta di bricolage e ho due mani sinistre. Ma se devo montare un comodino dell’IKEA prendo il foglietto delle istruzioni, le seguo pedissequamente e alla fine arrivo alla decenza. Lo stesso vale per montare il sottomarino della Lego, per compilare la nota spese con Concur, per collegare il mio telefono all’auto di cortesia.
Alla consuetudine, alle istruzioni, alla imitazione degli esperti, mi permetto di aggiungere che ci vorrebbe anche un po’ di perseveranza.
Se adolescenti inquieti riescono a sopportare certe lezioni di matematica che non finiscono mai, certe versioni di latino da 16 righe che li tengono inchiodati al Castiglioni Mariotti per tre ore filate, come è possibile che uomini adulti e in salute non riescano a stare composti prima che finisca il primo atto (a quel punto possono darsi alla fuga) anche se lo spettacolo non gli piace? Che debbano avere sete, caldo, bisogno di mandare un messaggio, di fare la pipì, di scattare una foto, di fare conversazione prima che ci sia un intervallo?
La incantevole nonchalance che ci dà la consuetudine può trasformarsi facilmente in goffaggine se veniamo trasportati in luoghi che non ci sono familiari. Anche l’Albatros di Baudelaire, trascinato dal cielo al ponte della nave, diviene goffo e brutto.
Ma l’essere neofiti non ci dà il diritto di essere ottusi. Dove manca l’istinto, dove latita l’educazione, dotiamoci almeno del manuale di istruzioni e di una briciola di resistenza.
In ogni modo non agitarsi e non disturbare aiuta.
-
In bilico tra Wim Wenders e Carlotta Clerici: dove sta il Perfect day?
La nostra amica Carlotta, compagna di studi in Statale ma ormai parigina d’adozione, ha scritto un libro Eloge de la passion,
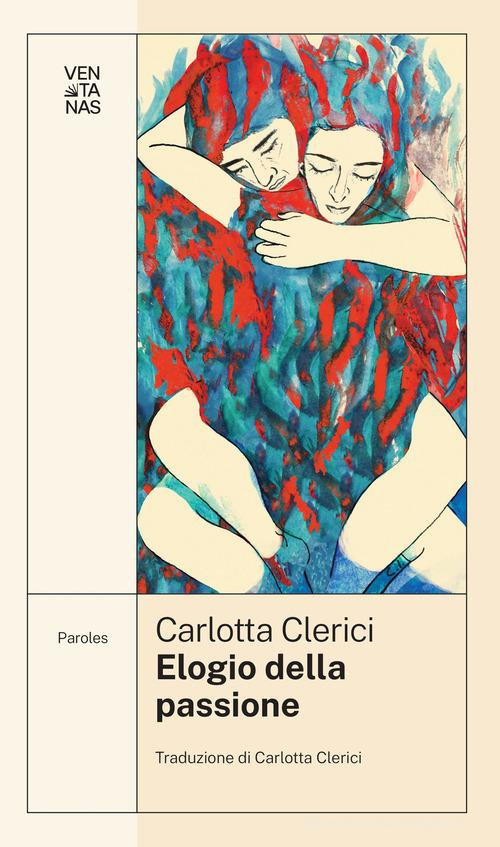
che ha finalmente tradotto in italiano (Elogio della Passione, editore Ventanas) e che ha presentato a Milano la scorsa settimana. Eravamo tanti (amici, prof, colleghi, ex mariti) a sostenerla alla Scatola Lilla, deliziosa libreria a pochi passi da Porta Romana.
La inquieta e volitiva Matilde, la protagonista del romanzo che assomiglia pericolosamente all’autrice, ha bisogno di incenerire quanto le sta attorno, per mettersi a costruire un paesaggio nuovo. Che magari non è migliore di quello passato (un trio musicale di successo, un marito, una figlia, una bella casa) ma ha il merito di essere nuovo, eccitante, doloroso e vibrante, rischioso e anticonvenzionale.
Mentre leggi il libro, senti quanto tutto ad un certo punto può andarti stretto. Quanto le tue relazioni ti paiano banali. Quanto il senso comune sia comune a tutti meno che a te.
Questa Anna Karenina dei sobborghi parigini alla fine non si suicida ma si ritrova sola, ferita e libera, senza rimpiangere ciò che ha perduto (neanche l’amante, semplice strumento, suo malgrado, della liberazione dalla routine noiosa e borghese in cui era rimasta incagliata). Finisce così che questa passione distruttiva faccia rinascere Matilde dalle sue ceneri. Dei comprimari (spiaccicati dalla esigenza del brivido) non abbiamo notizia.
Negli stessi giorni, molti di quelli che erano al reading, sono andati a vedere Perfetc days al cinema.
Hirayama, il protagonista del film di Wenders, conduce una vita silenziosa e contemplativa, fatta di piccoli gesti ripetuti. Pulisce i bagni pubblici di Tokio con meticolosità estrema, vive incontri semplici di cui si intuisce la pienezza. Si cura delle cose minute che lo circondano, annaffia le piante, fotografa le ombre degli alberi, ascolta musica anni ’70 con audiocassette di un mondo dimenticato. E’ un film dove non succede quasi niente, in cui lo sceneggiatore, per scrivere i dialoghi, non devono averlo pagato a cottimo. Sono giorni uguali a sé stessi, dove non c’è un passato, dove non c’è un futuro. Sono perfetti.
Chissà cosa succederebbe se gli occhi di brace di Matilde dovessero incontrare quelli pacificati di Hirayama; magari lei conoscerebbe la compassione, e lui un brivido ad agitare le acque limpide del suo presente.
-
Selezionare i migliori. Oppure no.
Chi cerca collaboratori, fidanzati, professori, dipendenti, allievi è molto concentrato sul trovare “la persona giusta”. Selezionatori con metodi divinatori, Intelligenza Artificiale predittiva, algoritmi che scartano a priori chi non risponde alle caratteristiche ideali disegnate a tavolino, amiche che analizzano il 730 del tuo ragazzo, complicati test d’ingresso alla facoltà dei tuoi sogni, assesment psico attitudinali che paiono l’indovinello della sfinge.

Con tutta questa energia dedicata a scegliere e scartare e selezionare dovremmo essere di fronte a aziende geniali che lavorano come orologi svizzeri, a coppie che sprizzano amore e energia da ogni poro, a servizi ineccepibili.
Dato che non è così, mi chiedo se un bravo manager, anziché passare il tempo a selezionare i migliori, non debba lavorare per far funzionare le risorse che ha a disposizione.
Il pigro ma divertente, l’intelligente ambizioso, l’ipercinetico organizzatore, il colto, il figo, il carrierista spietato, l’indolente belloccio, la sciura in pantofole, la fashion victim con i tacchi, l’assenteista, quello che fa notte, quello che si ammala.
Credo che gli esseri umani siano molto più simili tra loro di quanto non pensiamo (gli archeologi di domani, scavando nei nostri cimiteri, non saranno in grado di trovarci così diversi l’uno dall’altro, coperti di tatuaggi maori dalla Nuova Zelanda alla cerchia dei navigli). Forse vale la pena di metterci meno a sceglierli e più a formarli?
Credo che nella nostra vita a volte siamo stati i migliori e a volte i peggiori. Che la biodiversità nell’ecosistema aziendale funzioni (in squadra servono leader e gregari, anche a corrente alterna) e che a uno stipendio hanno diritto anche quelli che in gara non arrivano sul podio. Magari non faranno una carriera mirabolante ma dovranno bene, che diamine, portare a casa il loro salario anche se non sono Marchionne.
Una delle mie esperienze professionali migliori è stata in un’azienda in cui non c’era il budget neanche per accaparrarsi uno stagista, in cui la metà dei dipendenti (i migliori?) avevano dato le dimissioni prima che la barca affondasse. Il consulente del lavoro non selezionava, licenziava. Ebbene in questa atmosfera distopica (grandi uffici semi vuoti e Glassex sulla scrivania perché l’impresa delle pulizie, mai pagata, si era ammutinata), gestendo al meglio quello che c’era (le risorse umane, variegate in un mix di età, sesso, motivazione, e un magazzino esuberante di merce obsoleta) abbiamo portato in salvo buona parte dell’equipaggio e i valori di un marchio che ci ha poi fatto risorgere. Come Rossella O’Hara che si cuciva da sola l’abito da sera ricavato dalle tende di velluto, siamo riusciti ad andare al ballo. Lì non abbiamo sedotto il principe azzurro, ma almeno quello di Montecarlo, che ci ha finanziato abbastanza per sopravvivere e ricominciare.
Ho avuto una mamma che prima di essere mamma era un dottore. E’ stata iscritta all’ordine dei medici fino al suo ultimo respiro, definendosi un medico a riposo (la parola pensione non è mai stata pronunciata a casa nostra) quando non poteva più esserlo in corsia. Perché medico (direi di più: un ottimo medico) è stata sempre. Ma non credo che avrebbe passato i test di ingresso alla facoltà di medicina che oggi assillano i suoi giovani aspiranti colleghi.
Anche perché i “migliori” sono una categoria variabile, transitoria, soggettiva.
A volte i migliori sono degli out sider. Io lo sono stata per tutta la vita (out sider intendo): letterata prestata al conto economico; donna a occuparmi di collezioni uomo; bradipo a girare tra barche a vela e campi da tennis.
Se avessero fatto un filtro su laurea-in-economia/uomo/sportivo non avrei fatto niente di quello che ho fatto.
Per fortuna ho sempre abilmente dribblato i cacciatori di migliori, preferendo, di maieutica memoria, quelli che da me hanno cavato il meglio.
-
A lezione dal Preside
Venerdì sera tutte al Conservatorio. Il professore con cui ci siamo laureate avrebbe ricevuto il Premio Berchet , destinato agli ex allievi del liceo milanese che si siano distinti nella cultura e nell’arte.

Una bella occasione per ritrovarci tutte insieme . E un momento speciale per rivedere il prof a Milano, città che ormai gli è più simpatica da lontano: ha fatto 14 ore di volo per raggiungere il suolo natìo, noi 15 minuti a piedi per arrivare alla sala Puccini.
Se non ché il prof Paolo Bosisio , nel frattempo, ha guadagnato una celebrità inedita come preside del docu-reality “Il Collegio”.
Così ci siamo trovate parte di una platea dal calore straordinario. C’erano i suoi compagni di classe dei tempi del Berchet, i suoi studenti universitari di varie generazioni (noi prima leva dei laureati in Storia del Teatro) , i suoi ammiratori televisivi, adolescenti accompagnati da mamme con I Phone alla mano per immortalare i pargoli con il severo preside catodico.
Ci sono il rettore della statale Elio Franzini, l’ ex sovrintendente del Teatro alla Scala Carlo Fontana, Alessandro Cannavò (a fare l’intervista), i tecnici di palcoscenico che hanno collaborato ai suoi spettacoli, i cantanti d’opera (Bosisio ormai da molti anni è regista con predilezione per Puccini e Verdi) e una variegata macedonia di affettuosi amici che si abbracciano, sorpresi di trovarsi lì, dai quattro angoli del mondo, ad ascoltare e applaudire un Bosisio in stato di grazia per ironia, commozione e benevolenza.
Spiega ai giovani studenti del Berchet la differenza tra i tre soprani che si alternano sul palco (lirico, di coloritura, drammatico) con quel modo chiaro, generoso, divulgativo che ci ricorda le nostre lezioni in aula 211.
Le arie di Mimi, di Cho Cho San, di Tosca ci commuovono ulteriormente, mescolando i sospiri delle eroine sul palco a quello degli amici in platea.
Così alla fine della serata ce ne andiamo leggere, in una città illuminata da una luna spettacolare (la nebbia sarebbe arrivata solo sabato) con la sensazione che la vita può riservare sorprese formidabili e che anche i semi che abbiamo dimenticato di aver seminato un giorno si troveranno fioriti, magari tutti insieme, in una sala da concerto.
-
Rooftop&pool
Pare che il concept terrazza con piscina sia un trend dell’hospitality milanese.
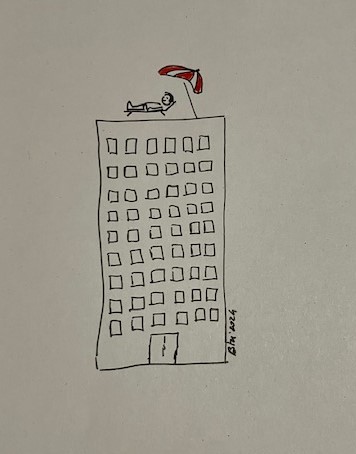
Business people abituati a stare a Milano giusto il tempo della firma di un contratto, hanno scoperto che la città si può anche un po’ godere (la città business diventa sempre più leasure, però il neologismo città Bleasure è orrendo e Milano non se lo merita neanche quando sogniamo di abbandonarla per sempre, neanche quando si allaga Niguarda, neanche quando c’è lo sciopero dei mezzi).
Il nuovo hotel VIU a Milano (zona Procaccini) ha una bella vista sulla città (otto piani a Milano sono già una vetta dolomitica) e una grande piscina lassù sul tetto (dalle 18,30 ci si può andare anche se non si soggiorna in Hotel). Vedere la città dall’alto con i piedi a bagno (soprattutto nell’estate incandescente) pare non sia per niente male.
Non si tratta però di una idea stravagante o inedita. Chi non sogna di prendere l’ascensore dalla propria stanza e, senza buttarsi nel traffico alla ricerca di un parcheggio da competere con gli indigeni, di trovarsi sul tetto della città?
Durante le vacanze di Natale (per uno strano pasticcio che magari approfondirò in un altro luogo) sono stata a Marsiglia anziché a Valencia. Nella città francese, ho visitato, grazie a Bobo (amico architetto e amante entusiasta di finestre a nastro e beton brut) , l’Unité d’habitation di Le Corbusier. Una città verticale immaginata nel 1947 (risposta al bisogno abitativo nel periodo post bellico) e realizzata nel 1952. Un prodigio di tecnologia (doppi vetri? piastre elettriche? cappa aspirante? ) mentre il mio immaginario di quegli anni è legato al bianco e nero del cinema neorealista.

Ebbene, sul tetto di questa icona dell’architettura, c’è un giardino, una piscina e una pista di atletica lunga 300 metri.
Con buona pace della vista di Milano, gli occhi si perdono verso il mare anziché verso il Monumentale
-
Qui si parla di tradimenti
Nel 2022, non so come mai, forse ci eravamo da poco liberati delle mascherine e avevamo endorfine a palla, intorno a me ci sono stati solo matrimoni, fidanzamenti, feste di anniversario con promesse di amore eterno.

A farci passare l’allegria nel 2023 sono circondata solo da cuori infranti. Da non poter clusterizzare: è successo a coppie sposate felicemente (almeno così ci sembrava) da 20 anni, a fidanzatini adolescenti che parevano Romeo e Giulietta, a adulti evoluti alla seconda puntata uniti da gusti comuni e appartamenti separati.
Ora, in nessuno di questi casi ci sono state cause esplosive (maltrattamenti in famiglia? fedi religiose/calcistiche/politiche incompatibili? uso di droghe? ludopatia? disoccupazione? depressione?), ma superclassici tradimenti.
Forse si trattava di partner noiosi? Amebe sdraiate sul divano dalle 20 alle 24? Casalinghe paranoiche con il Dyson acceso per tutto il fine settimana? Adolescenti brufolosi senza ambizione? No! In tutti i casi i cuori infranti erano brillanti (in questi giorni un po’ meno, stanno piangendo) e anche bellocci, a mio parere anche più brillanti della media (ma sono di parte, lo so).
Tutti i fedifraghi sono stati più o meno corretti e non troppo sgradevoli (a parte le bugie, vabbè ma se no come si farebbe a tradire?) e tutti gli abbandonati sono rimasti bene o male basiti, increduli e sorpresi. Ma non eravamo felici?
Quindi forse un minimo comun denominatore delle vittime lo possiamo trovare, non nel sesso o nell’età, ma nell’essere brillanti e parecchio ingenui.
Il che non va a loro merito (non li assumerei come investigatori) ma promette bene per il 2024: chi non avrebbe voglia di fidanzarsi con creativi e fedeli cerbiatti anziché con noiosi e meticolosi esploratori del vostro cellulare? Tempo di asciugare le lacrime. A fine anno prometto aggiornamenti a luci rosse
-
Alba sulla città
Gennaio è un mese difficile. L’eccitazione romantica di Natale è finita, le vacanze estive paiono lontanissime (ci sono prima le sfilate Fall Winter 24 e tutte le collezioni Spring Summer 25) e gli ostacoli per arrivarci sembrano piuttosto faticosi.

Di positivo (forse sembra impercettibile, ma è psicologicamente gigantesco) c’è che le giornate si stanno allungando. Ogni giorno 2 minuti in più di luce.
Si esce di casa ancora con il buio per andare al lavoro. Ma chilometro dopo chilometro la città diventa rosa e si vede l’alba e le strade che si stiracchiamo per iniziare a correre.
Dalla Vigevanese, con il cielo ormai lattiginoso, vedo stagliarsi davanti a me il palazzo Vodafone, appena dopo il Dazio. Le luci sono tutte accese anche se nessuno è ancora al suo tavolo. Forse una impresa di pulizie sta ripassando tutti i piani.
Il camion della spazzatura sta ripulendo la via Lorenteggio, ha i lampeggianti accesi e agili figure che saltano su e giù dalle piattaforme come da un gigantesco robot. In largo Giambellino stanno allestendo il mercato. Ancora troppo presto per veder tutto sui banchi.
Sulla darsena una luce rosa e arancione si specchia nell’acqua.

Passando per Viale Bianca Maria, ferma al semaforo, mi sembra di vedere per la prima volta il palazzo al civico 45, con i putti in bassorilievo su tutta la facciata. Che belle sono certe pietre grigie che diventano rosa al mattino presto.
Anche in via Calvi c’è il mercato del giovedì. Più chic però di quello del Giambe, con il banco di Valentino che vende il cachemire e quello dei fratelli Zingarelli con frutta e verdura così bella (e buona) che invita alla svolta vegana.
Finalmente corso Concordia, pieno di luce (la notte ormai è lontana) e da poche settimane senza più neanche una transenna: la fermata della M4 è finita e anche la ferita del tornado di luglio, che aveva abbattuto tutti gli alberi, manco fossimo a Miami, sembra dimenticata.
E’ vero i piedi sono in inverno, ma il cuore, quello, sogna già la primavera.
Villeggiatura20100
La vita vista da MI
